|
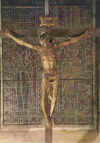 Donato Niccolò de' Bardi detto Donatello nacque a
Firenze nel 1386 e vi morì nel 1466. Fu
Scultore, tra i massimi del primo Rinascimento. Vissuto in un
momento particolare di evoluzione artistica, comprese appieno la
necessità di superare le rigidità tardo-gotiche per una nuova
libertà espressiva, profondamente realistica e umana, distante
nello stesso tempo dai canoni classici di cui proprio allora
fioriva l'entusiastica riscoperta. Fu il primo a comprendere che
una forma perfetta non è valida se non esprime uno stato
d'animo, una tensione umana e questo cercò di raggiungere nei
suoi lavori, in cui il primo elemento è la ricerca di
carattere, di definizione personale. Si può dire che Donatello
trasse dalla classicità gli elementi di perfezione tecnica, ma
trovò in se stesso e nella natura, con profonda verità e ansia
di ricerca, l'essenza audace della sua arte. Specie nei
bassorilievi (es. quelli bellissimi della basilica di S. Antonio
a Padova) raggiunse una visione di «espressionismo» pittorico
nel drammatico e intenso articolarsi di linee, luci e piani,
creando una specie di ideale ponte tra la profonda e cavernosa
passionalità medievale e la nuova espressività formale del
Rinascimento. Della formazione giovanile non si hanno notizie
certe; sappiamo con sicurezza solo che nel 1403 era fra gli
aiuti del Ghiberti per la seconda porta del battistero e
raffinava il suo disegno esercitandosi nella bottega dell'orafo
Cione de' Bardi. Le prime opere impegnative del Donatello furono
le due statue di Profeti per il duomo di Firenze, ancora
tradizionali nella forma, ed il più originale David (Bargello),
visto come uno spavaldo ragazzo fiorentino. Seguirono, un
Profeta per il duomo, la statua di S. Giovanni Evangelista
(Firenze, S. Maria del Fiore), di bella maestà virile, cui
sembra si sia ispirato Michelangelo per il Mosè, e il S.
Giorgio (Firenze, Museo, Nazionale), figura giovanile la cui
intensa fissità esprime arditezza e risoluzione. A queste
opere, caratterizzate da grande equilibrio, seguirono, nella
fiorente bottega fiorentina, altre in cui il Donatello, scavando
nervosamente le superfici, raggiunse effetti di intensa
drammaticità (statue destinate al campanile: S. Giovanni
Battista, Geremia, Abacuc). Gradatamente la luce divenne la
grande protagonista della sua plastica, scandendo i piani e
carezzando i volumi con effetti sempre nuovi, di pensosa
malinconia, di intensa drammaticità, di vitalità quasi
orgiastica. Ne furono esempi significativi Il banchetto d'Erode
(1427) per il fonte battesimale di Siena, l'Assunta per il
monumento Brancacci a Napoli (1427), le statue bronzee del
Davide e dell'Atys (Firenze, Museo nazionale), le porte bronzee
e i tondi in terracotta della sacrestia vecchia di S. Lorenzo
(Firenze). Dal 1443 Donatello operò a Padova dove eseguì i
drammatici lavori (statue e bassorilievi) per l'altare della
chiesa di S. Antonio ed il grande monumento equestre al
Gattamelata, dove la tensione della linea sorregge tutta una
compagine di ritmi incalzanti, di superfici compatte e luminose,
creando un effetto di grande e potente maestà eroica. Dopo
circa tre anni di quasi completa inattività, a Firenze (1458)
eseguì la statua bronzea del Battista (duomo di Siena), la
Maddalena (Battistero di Firenze) dal volto scavato e i fluenti
capelli che lambiscono membra quasi virili, il gruppo di
Giuditta e Oloferne (Firenze, Loggia dei Lanzi), creato
probabilmente con molti aiuti e di discusso valore estetico. Morì
senza aver potuto portare a termine i due pulpiti lignei per la
chiesa di S. Lorenzo ordinatigli da Lorenzo il Magnifico,
completati dagli scolari Bellano e Bertoldo. Donato Niccolò de' Bardi detto Donatello nacque a
Firenze nel 1386 e vi morì nel 1466. Fu
Scultore, tra i massimi del primo Rinascimento. Vissuto in un
momento particolare di evoluzione artistica, comprese appieno la
necessità di superare le rigidità tardo-gotiche per una nuova
libertà espressiva, profondamente realistica e umana, distante
nello stesso tempo dai canoni classici di cui proprio allora
fioriva l'entusiastica riscoperta. Fu il primo a comprendere che
una forma perfetta non è valida se non esprime uno stato
d'animo, una tensione umana e questo cercò di raggiungere nei
suoi lavori, in cui il primo elemento è la ricerca di
carattere, di definizione personale. Si può dire che Donatello
trasse dalla classicità gli elementi di perfezione tecnica, ma
trovò in se stesso e nella natura, con profonda verità e ansia
di ricerca, l'essenza audace della sua arte. Specie nei
bassorilievi (es. quelli bellissimi della basilica di S. Antonio
a Padova) raggiunse una visione di «espressionismo» pittorico
nel drammatico e intenso articolarsi di linee, luci e piani,
creando una specie di ideale ponte tra la profonda e cavernosa
passionalità medievale e la nuova espressività formale del
Rinascimento. Della formazione giovanile non si hanno notizie
certe; sappiamo con sicurezza solo che nel 1403 era fra gli
aiuti del Ghiberti per la seconda porta del battistero e
raffinava il suo disegno esercitandosi nella bottega dell'orafo
Cione de' Bardi. Le prime opere impegnative del Donatello furono
le due statue di Profeti per il duomo di Firenze, ancora
tradizionali nella forma, ed il più originale David (Bargello),
visto come uno spavaldo ragazzo fiorentino. Seguirono, un
Profeta per il duomo, la statua di S. Giovanni Evangelista
(Firenze, S. Maria del Fiore), di bella maestà virile, cui
sembra si sia ispirato Michelangelo per il Mosè, e il S.
Giorgio (Firenze, Museo, Nazionale), figura giovanile la cui
intensa fissità esprime arditezza e risoluzione. A queste
opere, caratterizzate da grande equilibrio, seguirono, nella
fiorente bottega fiorentina, altre in cui il Donatello, scavando
nervosamente le superfici, raggiunse effetti di intensa
drammaticità (statue destinate al campanile: S. Giovanni
Battista, Geremia, Abacuc). Gradatamente la luce divenne la
grande protagonista della sua plastica, scandendo i piani e
carezzando i volumi con effetti sempre nuovi, di pensosa
malinconia, di intensa drammaticità, di vitalità quasi
orgiastica. Ne furono esempi significativi Il banchetto d'Erode
(1427) per il fonte battesimale di Siena, l'Assunta per il
monumento Brancacci a Napoli (1427), le statue bronzee del
Davide e dell'Atys (Firenze, Museo nazionale), le porte bronzee
e i tondi in terracotta della sacrestia vecchia di S. Lorenzo
(Firenze). Dal 1443 Donatello operò a Padova dove eseguì i
drammatici lavori (statue e bassorilievi) per l'altare della
chiesa di S. Antonio ed il grande monumento equestre al
Gattamelata, dove la tensione della linea sorregge tutta una
compagine di ritmi incalzanti, di superfici compatte e luminose,
creando un effetto di grande e potente maestà eroica. Dopo
circa tre anni di quasi completa inattività, a Firenze (1458)
eseguì la statua bronzea del Battista (duomo di Siena), la
Maddalena (Battistero di Firenze) dal volto scavato e i fluenti
capelli che lambiscono membra quasi virili, il gruppo di
Giuditta e Oloferne (Firenze, Loggia dei Lanzi), creato
probabilmente con molti aiuti e di discusso valore estetico. Morì
senza aver potuto portare a termine i due pulpiti lignei per la
chiesa di S. Lorenzo ordinatigli da Lorenzo il Magnifico,
completati dagli scolari Bellano e Bertoldo.
|
